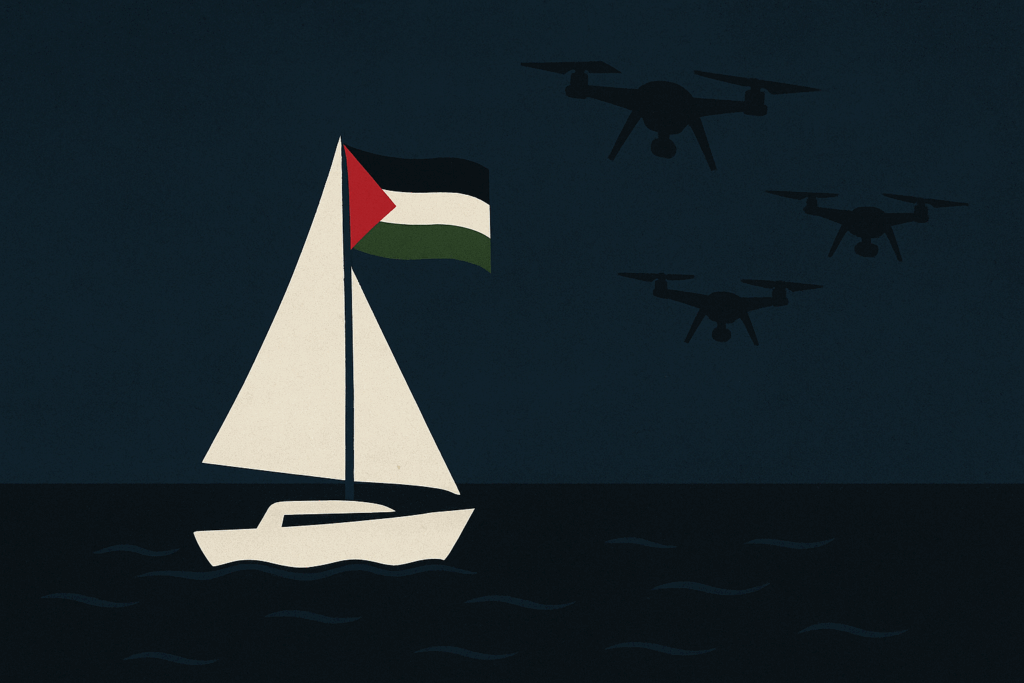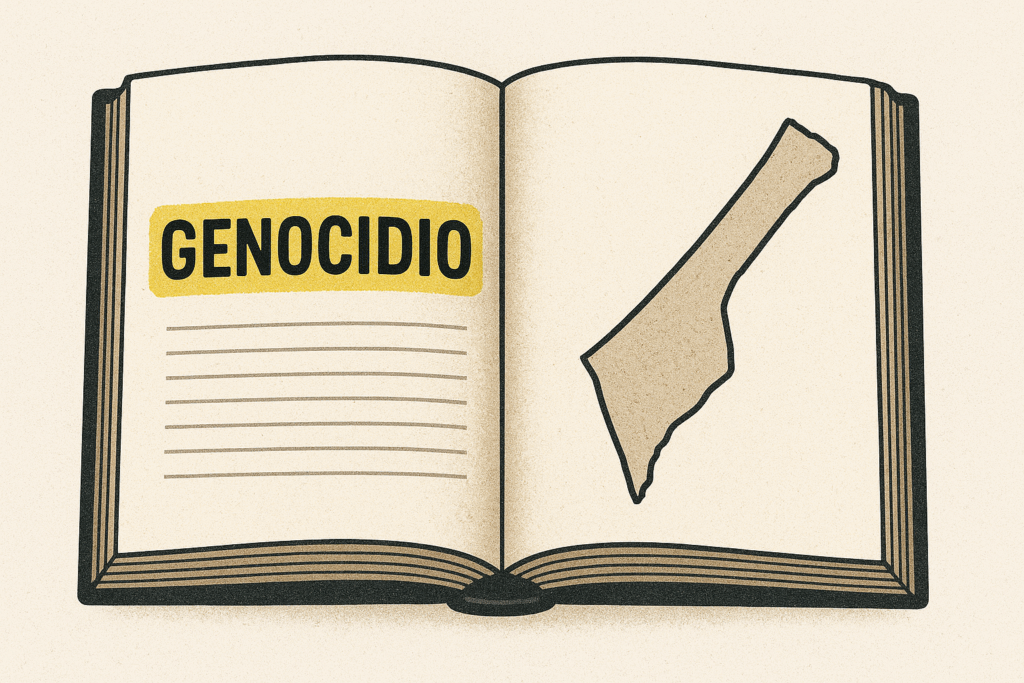L’appello di Sergio Mattarella alla Flotilla si distingue dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni per tono, registro e contenuti. Il presidente nomina la catastrofe umanitaria di Gaza e, così facendo, critica implicitamente Israele e riconosce il valore solidale dell’iniziativa. Si rivolge ai partecipanti con rispetto: «Mi permetto di rivolgermi con particolare intensità alle donne e agli uomini della Flotilla», scrive, chiedendo loro di accettare la mediazione del patriarcato di Gerusalemme per tutelare la propria incolumità e far giungere gli aiuti a Gaza in sicurezza. È un discorso elegante, persino opposto rispetto agli ordini e alle offese della presidente del Consiglio.
Ma resta un nodo irrisolto: come può lo Stato italiano proteggere i propri cittadini in acque internazionali e, allo stesso tempo, preservare il rapporto con un alleato che li attacca? Come può ribadire il diritto del mare e contestare un blocco illegale senza aprire un conflitto con Israele? Né le parole diplomatiche di Mattarella né quelle truculente di Meloni affrontano questo dilemma.
In modo raffinato, Mattarella sposta comunque sulla Flotilla la responsabilità di evitare lo scontro. Come ha riassunto Maria Elena Delia, portavoce della missione: «Non possiamo chiedere a Israele di non attaccarvi, chiediamo a voi di scansarvi». Il presidente avrebbe potuto premettere che Israele non può colpire cittadini italiani in acque internazionali e ricordare che il blocco di Gaza è illegale.
Nel discorso di Capodanno 2023, parlando dell’Ucraina, Mattarella disse: «La responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito e non su chi si difende o su chi lo aiuta a difendersi». Esprimeva così il principio del rifiuto del precedente. Ora, per la libera navigazione e per la tutela del diritto umanitario, quel principio non merita di essere ribadito? Se i droni contro i nostri cittadini in mare fossero russi, lo accetteremmo?
Rivolgendosi solo alla vittima potenziale, il messaggio implicito diventa: “Voi siete l’unica parte su cui possiamo esercitare un’influenza per evitare il disastro. A voi chiediamo un passo indietro”. Il comportamento di Israele, invece, è trattato come un dato di natura: la sua “prevedibile reazione violenta” viene normalizzata e accettata come un confine invalicabile dell’azione politica.
Colpisce l’assenza di un richiamo al diritto internazionale, in particolare all’illegittimità degli attacchi in acque internazionali. È una mancanza grave dal punto di vista della tutela dei cittadini. Anche volendo evitare uno strappo con Israele e Stati Uniti, non può essere solo l’Italia a farsi carico della salvaguardia dell’alleanza: se siamo alleati e non subalterni, l’onere deve essere condiviso.
Il presidente offre alla Flotilla una corona d’alloro morale in cambio del suo ritiro dalla linea del fuoco: una via d’uscita onorevole, ma al prezzo di accettare che la legge del più forte prevalga sul diritto internazionale. Quanto alla mediazione, va ricordato che il patriarcato di Gerusalemme può impegnarsi a consegnare gli aiuti ma non garantirne l’ingresso, perché Israele blocca gran parte dei carichi ai valichi.
Al porto di Genova: dieci container con 300 tonnellate di cibo raccolto da Music for Peace restano bloccati da settimane. Perché? Israele e i suoi intermediari hanno chiesto che venissero tolti dai pacchi biscotti, miele, marmellate e altri alimenti ad alto valore energetico, imponendo anche ai volontari di pagare lo smaltimento e il trasporto aggiuntivo. Condizioni «irricevibili», come le ha definite la ong, che ha preferito bloccare la trattativa piuttosto che accettare di trasformarsi in complice di un meccanismo che affama Gaza.
Non è un episodio isolato: i divieti sui datteri perché considerati “cibo di lusso” o sulle patate perché “si conservano troppo a lungo” mostrano come Israele stia usando la fame in modo deliberato, burocratico, scientifico. E se l’Europa e l’Italia accettano queste regole, pur di far arrivare qualche briciola, finiscono per legittimare l’arma più crudele. In queste condizioni, la mediazione meglio intenzionata rischia di ridursi a un inganno per l’opinione pubblica.